| Fr. Teodoreto proiezione moderna di S. G. Batt. De La Salle |
B203-A3
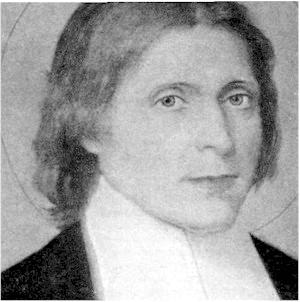
Ad affiancare le due figure di S. Giovanni Battista de La Salle e del Fr. Teodoreto risaltano immediatamente molti tratti di perfetta concordanza.
Assai diversi per epoca ed ambiente, s'incontrano nell'individuare i valori essenziali della vita, nell'operarne una personale assimilazione e nell'inculcarne agli altri la conoscenza ed il perseguimento.
Né l'uno né l'altro ebbero doti di brio, di prontezza dialettica, di vigoria fantastica, di incisività stilistica.
La loro parola era formalmente disadorna, il loro pensiero possedeva più sostanza che rilievo, la loro argomentazione era piana e priva di scatti.
Pacati e riflessivi, non conoscevano l'arte di eccitare e di catturare l'immaginazione dei loro ascoltatori.
Erano totalmente estranei a qualsiasi tecnica e facoltà psicagogica.
Non furono dei trascinatori; convincevano, ma senza far leva sul sentimento; la loro forza consisteva in una chiara persuasione razionale vivificata da una limpida luce soprannaturale.
Non si atteggiarono mai a profeti, disdegnando il turgore che il ruolo facilmente implica e la componente di esaltazione che vi è sovente incrostata.
Erano persuasi che i soli profeti autentici fossero quelli che non se ne assumevano i paludamenti e che non si proclamavano tali dinanzi a tutte le platee.
Profeti lo furono davvero, perché lo furono nei fatti, che è l'eterno crinale che separa i fecondatori della storia dai presuntuosi, dagli esaltati, dai ciarlatani.
Non si proposero di ribaltare la società del loro tempo, come fanno tutti i visionari di ogni età, ma di lievitarla dall'interno: e a questo scopo predicarono ma soprattutto praticarono.
Intuirono la precarietà dell'eloquenza e la forza dell'esempio; sentirono che la dialettica che penetra fin giù, dove si prendono le decisioni che impostano definitivamente le esistenze, è farsi modelli discreti ma decisi.
Non furono intellettuali, furono - per loro e per nostra fortuna - soltanto intelligenti.
Come il Cardinal Federigo Manzoniano, badarono alle massime trasmesse nel più elementare insegnamento della religione, le presero sul serio, le gustarono, le trovarono vere e le vissero con coerenza; furono come il « ruscello che, scaturito limpido dalla roccia, senza ristagnare né intorbidarsi mai, in un lungo corso per diversi terreni, va limpido a gettarsi nel fiume » ( Promessi Sposi, cap. XXII ).
Misero a fondamento della loro fede un forte studio della Bibbia e della dottrina insegnata dalla Chiesa, in tutte le sue ramificazioni essenziali, dalla dogmatica all'apologetica, dall'ascetica alla pastorale; se ne persuasero grazie alla luminosa ed organica coerenza con cui essa affronta e risolve tutti i problemi, corrisposero alla dinamica sollecitazione della grazia e poi proseguirono.
Non difettarono di robusti fondamenti concettuali, ma non vi si richiamarono perennemente in un'ansiosa verifica, causa ed effetto di una nevrotica insicurezza psichica.
Nessuno dei due fu un genio speculativo, ma entrambi furono menti solide e chiare.
Non volarono mai, però camminarono sempre, senza pigre soste o frustranti ritorni.
Seppero costruirsi delle basi che non ebbero bisogno di ulteriori infiltrazioni di cemento rassodatrici.
Nel loro ambiente tracciarono - evangelicamente - un solco e fu un solco diritto.
Fu questo uno degli elementi che catalizzarono la fecondità della loro azione.
Fecero molta strada, perché tennero sempre d'occhio la bussola che assicurò loro una direzione di marcia tutelata da qualsiasi deviazione: avanzarono sempre, metodicamente, portandosi i principi dentro di sé.
Partiti dalla Genesi, giunsero presto all'Esodo; dopo aver fortemente meditato che « in principio Dio fece il cielo e la terra », si chiesero che cosa allora dovessero fare essi e si misero all'opera.
Resistettero alla subdola tentazione delle girandole raziocinatrici, delle variazioni teoretiche senza fine, delle trattazioni iperuraniche fatte di pompose ma sterili fronde intrecciate che soddisfano assai gli oratori, compiacciono gli oziosi, ma lasciano a brancolare nel buio quanti chiedono suggerimenti fattivi.
Forniti di un saldo equilibrio, seppero connettere, con limpida naturalezza, idea ed azione, in modo che l'una non rimanesse infeconda e l'altra gratuita perché immotivata.
Entrambi ebbero l'alto buon senso di non presentarsi come latori di un messaggio rivoluzionario.
Capirono che l'unico genuino messaggio nella storia fu recato da Cristo e che di quello essi erano non gli scopritori ma i beneficiari, ed intuirono che la sola rivoluzione, che non sia violenza criminosamente ed impotentemente distruttrice, è quella da Lui annunciata nel Vangelo ed affidata alla Chiesa come banditrice ufficialmente autorizzata.
Il messaggio rivoluzionario lo vissero, nel raccoglimento interiore di un diuturno ripensamento che era approfondimento ed applicazione.
Questa continua illuminazione all'interno fioriva in convinzioni le quali si traducevano poi all'esterno in un'attività improntata alla sicurezza di chi vede la via.
Entrambi conobbero ostacoli - innumerevoli ed enormi! - e si imbatterono in dubbi, che concernevano però i metodi contingenti e non i fini sostanziali.
Furono travagliati da incertezze specifiche, ma mai da crisi.
Le crisi di identità sono sempre crisi di fede; le tentazioni sulla vocazione non nascono dalle difficoltà storiche ma da quelle psicologiche; i lamenti sulla refrattarietà del mondo sono alibi, coscienti o no.
Tanto S. Giovanni Battista de La Salle quanto Fr. Teodoreto iniziarono attività che stentarono assai ad accestire; la loro missione incontrava un successo assai limitato e travagliato.
Tuttavia non dubitarono mai: non soccombettero alla lusinga di voler misurare i frutti.
Sapevano che lo Spirito Santo non tiene quaggiù segretari della sua contabilità e che Cristo li aveva inviati a seminare, riservando a sé ed ai suoi angeli la mietitura nella stagione escatologica.
Andarono quindi fidenti; in mezzo alle traversie conservavano la parte più elevata del loro spirito immersa nella serena chiarità di una sublime certezza; si sentivano risuonare nell'anima alcune parole: « Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo » ( Gv 16,33 ); « Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno » ( Mt 24,35 ); « Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo » ( Mt 28,20 ) …
Da queste altezze i contrattempi venivano automaticamente a ridimensionarsi e le resistenze si rivelavano nella loro meschina inconsistenza.
Essi possedevano la tremenda forza della fede, perciò erano così tranquillamente calmi.
Interpretavano le veementi tempeste scatenate dagli avversari come vane scaramucce; dinanzi alle impetuose offensive dei nemici, quando sembrava che l'unica presenza fosse quella degli altri, che gli altri fossero ondata travolgente che tutto avrebbe spazzato via, non si sgomentarono: sapevano che dinanzi a Lui il fragore di quelle burrasche si sarebbe dissello in un tenue sciacquio, come un giorno sul lago di Tiberiade.
Tutte le camicie - verdi, azzurre, rosse, nere, brune … - si sdruciscono rapidamente a stracci e tutte le insegne vengono con impressionante prontezza erose dal tempo: solo la Croce sfugge all'opera disgregatrice degli anni.
Ci sono delle sicurezze che infondono nell'anima una pace ed una vigoria senza confini … ed anche una fierezza immune sia dalla paura che dalla millanteria.
Entrambi si presentarono infatti - a viso aperto - come evangelizzatori: « non arrossirono per nulla del Vangelo » ( Rm 1,16 ).
Il loro magistero didattico si incentrò su di esso: la loro preoccupazione fu di spiegarlo con tanta perspicuità che arrivasse alle menti di tutti gli alunni ed il loro metodo fu di porgerlo con la massima immediatezza.
Non provarono nessun batticuore alla prospettiva di parlare di Cristo e della Chiesa agli adolescenti, non si vergognarono di credere nel soprannaturale, non cedettero alla pretestuosa viltà delle precatechesi, non s'impastoiarono nei tremebondi approcci delle introduzioni, non sostituirono l'annuncio con la lettura di romanzi vagamente sfarfallanti attorno a qualche tematica infiorettata di fronzoli nazareni, non snaturarono il cristianesimo a sociologia, non ridussero il peccato ad ingiustizia salariale, non restrinsero gli orizzonti alla terra e l'eternità al tempo.
Seguendo la prassi di Gesù e degli Apostoli andarono subito al cuore delle questioni: s'ingegnarono non a stendere ma a rimuovere i veli.
La loro gradualità fu psicologica e non teologica.
Aborrirono ogni mimetizzazione.
Attestarono senza infingimenti la loro reale identità: il S. Fondatore si proclamò "prete romano" contro gallicani e giansenisti, e Fr. Teodoreto "catechista" contro marxisti e fascisti.
Posto a centro ed a fondamento della scala dei valori il soprannaturale, nel loro profondo equilibrio non misconobbero la validità della sfera terrestre.
L'uomo, collocato dal piano divino a cerniera vivente dei due mondi dello spirito e della materia, di entrambi deve attuare la positività, misurando la propria perfezione dall'armonica completezza della loro integrazione.
Il S. Fondatore e Fr. Teodoreto non istituirono un antagonismo tra cielo e terra: né distinsero i pregi, ma assai più per coordinarli che per contrapporli.
La loro carità era comprensiva piuttosto che selettiva, come la loro intima religiosità, se era fortemente segnata dall'ascetismo, recava solo sfumate e marginali tracce di misticismo.
Entrambi subordinarono - ovviamente - la ragione alla fede, ma non respinsero la ragione in nome della fede, anzi impegnarono la prima con tutte le sue risorse per un più pieno raggiungimento della seconda.
Nella natura e nell'umanità scorsero non tanto un destino di allontanamento da Dio, quanto un anelito - spesso implicito, ma non perciò meno potente - di ritorno a Lui: anche il peccato parve loro, generalmente come una debolezza che aspira al riscatto.
Essi si sentirono inviati a diffondere nel mondo la luce di Dio ed a svelare l'impronta del Creatore in tutte le creature.
Non si lasciarono quindi mai agitare da intransigenti disdegni verso le realtà terrestri: accanto ai limiti ne individuarono i valori.
Cristianesimo fu per loro purificazione degli esseri contingenti nel loro collegamento con l'assoluto: la piramide riscattava la base proprio sottoponendola e connettendola al vertice.
Espressione evidentissima di questa loro "forma mentis" fu la collocazione dell'insegnamento religioso nei loro programmi: al culmine, certo, ma anche inserito tra quelli profani.
Vollero che i loro discepoli fossero catechisti ed insieme insegnanti.
Il sacro per loro non escludeva il profano; lo purificava e lo nobilitava pur senza distorcerne mai la natura: una siffatta forzatura sarebbe infatti stata una mistificazione che avrebbe immiserito, non sublimato, l'universo.
Essi riscopersero la purezza originaria della creazione.
La scienza e la cultura apparvero quindi ai loro occhi come un pellegrinaggio alla ricerca delle orme creatrici di Dio ed ogni nozione acquisita o trasmessa divenne un bagliore della rivelazione: ogni verità era pure un raggio promanante dalla Verità.
Preconizzarono pertanto nei loro figli spirituali una cultura quanto più possibile vasta e profonda ed insistettero perché, a qualunque livello, fosse soprattutto limpida e tersa.
Universali nel valorizzare la manifestazione di Dio sia attraverso alla via diretta della rivelazione che attraverso a quella indiretta della creazione, alieni da qualsiasi delimitazione nell'apertura culturale, essi furono universali ed avversi a qualunque discriminazione anche per quanto concerne i destinatari della loro azione illuminatrice.
Per un impulso nel quale concorrevano sanità di temperamento e lucidità d'intelligenza rifuggirono da ogni transenna: nella loro magnanimità non riuscirono ad immaginare esclusioni.
Il comando di sviluppare i talenti ricevuti e la vocazione a conoscere e ad incontrare il Padre erano imperativi così sublimi e così finalizzati all'eterno che qualunque considerazione di ceti al riguardo sarebbe apparsa loro assurda prima ancora che mostruosa.
Di fronte all'importanza decisiva della salvezza non riconobbero ordini di preferenza né in accordo né in contrasto con l'ammontare dei redditi.
Al cospetto di Dio non esistono infatti classi e così all'interno della Chiesa sarebbero blasfemi degli steccati eretti sul metro di quella miserrima cosa che è il denaro.
Scegliere? Fu forse l'unico problema che non si presentò mai al loro spirito: d'istinto scelsero tutti, come S. Paolo che « si rese servo di tutti per guadagnare il maggior numero possibile … e si fece tutto a tutti per salvare tutti » ( 1 Cor 9,19-22; vedi inoltre Rm 8,32; 1 Cor 12,13; 2 Cor 5,14-15; Gal 3,28; Ef 1,23; Ef 4,6.13; Col 3,11; 1 Tm 2,6 ).
Anch'essi ebbero una sola cura: arrivare a quanti più potessero.
S. Giovanni Battista de La Salle istituì scuole per gli umili popolani di Parigi, per la borghesia commerciale di Boulogne, per l'alta nobiltà inglese che seguì in Francia il re Giacomo II e Fr. Teodoreto si prodigò con la medesima totalità di zelo tra i ragazzi della Regia Opera Mendicità Istruita e tra quelli del Collegio San Giuseppe.
Entrambi capirono che sulle anime non si cuciscono galloni né si appuntano cartelle di somme d'imponibile.
Non scartarono, accolsero; non dissero no a nessuno, il no lo disse loro soltanto l'esaurimento delle forze.
Incominciarono con chi trovarono più vicino, non con chi preferirono; non anticiparono giudizi settari sui reprobi e sugli eletti.
L'immensa grandezza della chiamata alla vita divina e la sua drammatica urgenza polarizzarono così intensamente i loro sguardi che non permisero loro di sviarsi immiserendosi in priorità che sotto una buccia di miope generosità celano angustia d'anima e meschina acquiescenza al vento dell'ora.
Si avvidero subito che la povertà dinanzi alla grazia era una categoria ontologica, irriducibile a criteri valutari.
Entrambi osservavano le cose umane troppo dall'alto e con un cuore troppo ampio per non espandersi sulla terra come facevano per le plaghe del cielo.
Erano grandi, ma di una grandezza che sdegnava gli abiti sgargianti ed i brillii abbacinanti.
La loro era un'eccellenza avvolta dal grigio della quotidianità: non era agevole da cogliere, perché amava penetrare nell'intimo delle azioni invece di stazionare alla superficie.
Si faceva forse presto ad accorgersi che in loro c'era qualcosa di particolare, e tuttavia la sua individuazione esigeva del tempo: veniva fuori solo al lento ma infallibile esame dell'esperienza.
Essi erano di quegli uomini rari le cui frasi emergono spontanee, a distanza, come illuminazione improvvisa di eventi e sentimenti complicati; lì per lì la loro sapienza poteva essere schermata da una semplicità che odorava di ovvio, ma i problemi della vita ne rivelavano poi le dimensioni effettive, ed allora saliva alle labbra il commento stupito: « Aveva ragione! ».
Anche nel dominio della esistenza consueta erano dei rivelatori.
Furono uomini che tracciarono strade sicure con uno straordinario senso di orientamento.
Il loro segreto fu una sorprendente comprensione di Dio e dell'uomo, oggetti che divergono solo ad una riflessione epidermica, mentre si compongono in una meditazione diuturna e profonda: essi riuscirono con la naturalezza della sincerità a ricuperare tutti i valori.
La loro penitenza fu l'opposto di un'automutilazione e la loro austerità, scavalcando la rinuncia, l'annullava in un'acquisizione di suprema ricchezza.
Furono insaziabili assimilatori e diffusori di quanto al mondo c'è di autenticamente buono, vero, bello ed ebbero perciò lo spirito immerso in una costante immensa serenità.
Nel generale smarrimento in cui vanno travolti alla deriva tanti nostri contemporanei, essi hanno sicuramente ancora una parola da dire: ma secondo il loro stile, assai diversa da quella roboante che ci frastorna e rintrona attraverso ai mezzi di comunicazione sociale, ed è appunto perciò una parola sostanziosa e datrice di energia e di luce; è una parola bisbigliata sottovoce, come sono tutte quelle che servono a guidare e non a confondere.
A riflesso del più puro soprannaturale essi seppero interpretare il mondo naturale con quel sovrano equilibrio che è anche la forma più preziosa d'intelligenza.
Santità, meditazione, equilibrio: le loro grandiose ricchezze, le nostre disastrose carenze.
Essi sono prepotentemente moderni, non foss'altro che per l'angoscioso bisogno che noi abbiamo di queste loro splendide doti.
Fr. Enrico ( Collegio San Giuseppe )
