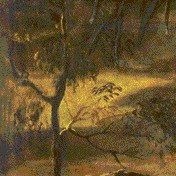| Catechismo degli Adulti |
Dio educa il suo popolo alla preghiera
Cat. Chiesa Cat. 2566-2625
956 La pratica religiosa oggiLa cultura secolarizzata e il ritmo incalzante della vita moderna hanno provocato una diminuzione della pratica religiosa. Meno della metà della gente nel nostro paese dichiara oggi di pregare frequentemente; gli altri dicono di farlo raramente o addirittura mai. Per altro verso c'è da parte di molti una riscoperta della preghiera, che si manifesta nell'entusiasmo collettivo di grandi folle, nel fervore di piccoli gruppi, nella ricerca del silenzio e della solitudine, nelle vocazioni alla vita contemplativa. A quali sorgenti si alimenta questa esperienza sempre viva? Quali riferimenti abbiamo per educarci alla preghiera? |
||||||
957 Dialogo vivo con Dio |
|
|||||
I gesti, con cui l'uomo rivolge consapevolmente l'attenzione alla divinità e invoca il suo aiuto per avere vita e felicità, occupano da sempre un posto centrale nelle religioni. Alla luce della rivelazione sappiamo che l'uomo cerca Dio perché Dio cerca l'uomo e lo attrae a sé. |
||||||
958 Nell'Antico Testamento Dio si fa interlocutore personale del suo popolo mediante una storia di eventi e parole; crea un legame speciale di alleanza. |
|
|||||
La preghiera è ascolto della sua parola e risposta ad essa; è dialogo in cui, al di là della dipendenza creaturale, viene vissuto consapevolmente il rapporto di alleanza. Abramo vive l'intimità con Dio come ascolto attento, obbedienza, abbandono fiducioso nelle prove e intercessione audace per i peccatori. ( Gen 15,1-6; Gen 18,16-33; Gen 22,1-19 ) Mosè, confidente e cooperatore di Dio, presenta le sue difficoltà, ma obbedisce; intercede con perseveranza per il popolo. ( Es 4,1-17; Es 32,11-13 ) I profeti hanno un'esperienza diretta di Dio, che li sostiene in mezzo alle tribolazioni. Cercano appassionatamente il suo volto; lavorano e lottano per la sua causa. Chiamano Israele a una preghiera che non sia solo un insieme di cerimonie esteriori, ma conversione del cuore e osservanza dei comandamenti. ( Is 1,10-17; Ger 1,17-19; Ger 20,7-9.11; Am 5,21-24 ) |
||||||
|
||||||
959 I salmi |
|
|||||
Per alimentare la preghiera del suo popolo, Dio ispira i salmi, mirabili formule adatte per la comunità e per i singoli. Vi si fa memoria delle meraviglie che egli ha compiuto in passato; si richiamano le sue promesse, di cui si attende il compimento. Dentro questa storia dell'alleanza viene inserita la situazione di chi prega. Vi trovano espressione tutti i sentimenti umani: gioia e desolazione, gratitudine e desiderio, contemplazione e impegno, fiducia e protesta, compassione e ira. Ma l'anima di tutto è sempre la lode di Dio; perfino la sofferenza e l'ingiustizia diventano nella speranza motivo di benedizione. Appare dunque appropriato il titolo "I salmi" o "Le lodi", che è dato all'intera raccolta. L'assenza di riferimenti episodici facilita l'attualizzazione. I salmi sono stati impiegati per secoli nella liturgia delle sinagoghe ogni sabato e nella liturgia del tempio in occasione delle feste. Il Signore Gesù se ne è servito per lodare e invocare il Padre, conferendo ad essi un nuovo significato alla luce della nuova alleanza. Da lui e non solo dal popolo d'Israele li riceve la Chiesa. |
||||||
960 Dialogo filialeGesù introduce nella storia la preghiera filiale: la vive in prima persona e la comunica ai credenti. Prega molto durante la vita pubblica: loda e ringrazia il Padre, accoglie con prontezza la sua volontà. ( Mt 11,25-27; Lc 10,21-22 ) Prega all'avvicinarsi dell'"ora" decisiva della morte e risurrezione. |
|
|||||
Elevando al Padre quella che giustamente viene detta "Preghiera sacerdotale", ( Gv 17,1 ) richiama tutto il disegno di Dio che si sviluppa nella storia della salvezza, dà voce all'anèlito universale verso la comunione trinitaria, perché tutto giunga a compimento. Prega durante la passione: ( Mc 15,34; Lc 22,42; Lc 23,34.46 ) "Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà" ( Eb 5,7 ). Prega con una confidenza del tutto singolare, chiamando Dio: "Abbà" ( Mc 14,36 ). Incarna nella sua esperienza umana l'atteggiamento del Figlio unigenito, eternamente rivolto al Padre. |
||||||
961 Gesù fa partecipare i credenti alla sua comunione filiale e li educa a viverla consapevolmente nella preghiera. Insegna il "Padre nostro"; ( Mt 6,9-13 ) esorta a chiedere
soprattutto il dono dello Spirito Santo; |
|
|||||
I discepoli devono pregare nel suo nome, ( Gv 14,13-14; Gv 16,23-24 ) in sintonia con lui e insieme a lui, perché si compia il disegno del Padre. La preghiera cristiana è la preghiera stessa di Gesù comunicata ai suoi. |
||||||
962 Esperienza ecclesialeLo Spirito del Signore sostiene e guida la preghiera dei figli di Dio, perché si rivolgano al Padre con lo stesso atteggiamento di Gesù. ( Rm 8,15; Gal 4,6 ) Fa della Chiesa un'esperienza assidua di preghiera, fin dall'inizio del suo cammino storico. ( At 1,14; At 2,42 ) Da persona a persona, da una generazione all'altra, sotto la guida dei pastori, il linguaggio e l'atteggiamento della preghiera si comunicano come per osmosi, dando luogo a tradizioni liturgiche, teologiche e spirituali. I grandi maestri e modelli sono soprattutto i santi. Gli ambienti dove ci si educa a pregare sono in concreto le parrocchie, specialmente attraverso l'assemblea festiva, i santuari, in occasione soprattutto di pellegrinaggi, le comunità religiose, le aggregazioni particolari di fedeli e, con una efficacia tutta propria, le famiglie cristiane, dove i figli imparano dai genitori a sentire la presenza di Dio, a intrattenersi con lui al mattino e alla sera, a benedirlo per la mensa e per tutti i suoi doni. |
||||||
Cat. Chiesa Cat. 1674-1676 |
||||||
963 La religiosità popolareLa formazione alla preghiera passa anche attraverso la religiosità popolare: idee, atteggiamenti, simboli e comportamenti riguardanti la realtà religiosa, condivisi e tramandati in un gruppo sociale. Le sue espressioni privilegiate sono i riti di passaggio da una fase all'altra della vita, il culto dei defunti, le feste e le ricorrenze, l'inclinazione a credere nei miracoli e nelle apparizioni, la venerazione di immagini e reliquie, le processioni, i pellegrinaggi ai santuari. Le singole persone vi trovano protezione contro la precarietà e l'ansia, che insidiano l'esistenza. La pietà popolare ha senz'altro dei limiti. Tuttavia "non può essere né ignorata, né trattata con indifferenza o disprezzo, perché è ricca di valori, e già di per sé esprime l'atteggiamento religioso di fronte a Dio. Ma essa ha bisogno di essere di continuo evangelizzata, affinché la fede, che esprime, divenga un atto sempre più maturo e autentico".1 L'evangelizzazione non distrugge, ma assume ciò che trova di buono, lo purifica e lo perfeziona.2 Così, ad esempio, la pastorale dei santuari a volte integra felicemente quella delle parrocchie, offrendo occasioni privilegiate di conversione e di formazione. |
||||||
964 La preghiera cristiana, animata dallo Spirito Santo e inserita nella tradizione vivente della Chiesa, è partecipazione al colloquio filiale di Gesù con il Padre. |
||||||
| Indice |
| 1 | Giovanni Paolo II, Vigesimus quintus annus 18 |
| 2 | Lumen Gentium 17 |